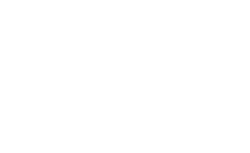Quando l’interiore cura l’esteriore
a cura di Amerigo Brunetti.
Tutte le foto: Elis Bonini
Sono in cucina, seduto. Decido di alzarmi dalla sedia.
Non posso cadere.
E’ un’azione elementare, familiarissima, facile.
Inizio seriamente a pensare che – ad alti livelli – la “tecnica” sia questione di pensiero, immaginazione. Capacità di visualizzare con assoluta realtà e precisione il movimento che compio.
Riassumere il lavoro di quattro miliardi di sinapsi in un solo nucleo.
Quanto si vede da fuori è in realtà il semplice risultato di un’idea che abbiamo in testa durante l’esecuzione.
Ogni soggetto mette in pratica – in base alle sue proporzioni fisiche, alle leve e alle proprie capacità di attivazione di determinati settori – un’idea di movimento.
Soprattutto se non siamo allenatori, focalizzarsi su come esegue la panca il campione di turno potrebbe non avere senso. Molto più interessante, invece, capire a cosa sta pensando quell’atleta durante il gesto. Ovvero come interpreta il movimento. Cosa visualizza. Quale immagine ha di fronte agli occhi. Non che sia un’immagine necessariamente conscia: molti vi potrebbero rispondere che non pensano a niente, pensano a spingere.
Ma se un atleta di livello chiude gli occhi e si concentra, vede “Lo squat”. Vede “La panca”.
Rivive il movimento.
A cosa ha pensato durante gli allenamenti, a cosa ha pensato quando era piantato di panca e – da un mese all’altro – il suo massimale ha ripreso a salire?
Che forma ha lo squat nella sua testa? Intendo proprio a livello astratto, non le solite regoline: “penso a stare iperesteso, penso a sentire i piedi”.
Queste il campione le va via via perdendo, lasciando spazio, appunto, a quell’unicum: l’idea che lo guida verso la performance estrema.
E’ molto difficile che siano state risolte situazioni critiche dicendo semplicemente di chiudere i gomiti o suggerendo di attivare selettivamente il rombiode piuttosto che il trapezio.
Molto difficilmente un campione pensa a sentire il gran dorsale mentre è sotto a 300kg di panca.
Il Testa di Serie ha davanti agli occhi l’essenza sinestetica del muoversi.
Otoliti nella posizione x-y-z, percezioni tattili, pressorie e di temperatura, organi del golgi sirati all’inverosimile o solo blandamente accarezzati, ileo psoas in tensione, immagine riflessa nello specchio, magnesio ruvido nell’aria, guardo il bordo della pedana, corpetto e cinta strangolano le viscere, la musica vibra, rumore delle fasce che mordono la pelle.
Fusi in un’unica entità.
Niente pensieri collaterali, niente spalle basse o culo indietro. Niente duro con la pancia, niente iperestendi. Niente di niente: solo un’immagine.
A parole impossibile, inafferrabile, inspiegabile, ma precisissima per chi la vive.
Non se ne può parlare concretamente, è un’idea. Ma con gli anni di allenamento la si trova. A volte insieme, a volte in due. Spesso. E’ a questo che serve l’allenatore. A entrare dentro e vedere cosa e come smuovere. E’ per questo che qualcuno ha detto che i pesi sono un settore molto più “umanistico” che “scientifico”.
Alla fine, per essere un bravo allenatore, è tutta questione di comunicazione.
Capacità di percepire cos’ha in testa il nostro allievo mentre si allena.
I tecnici da tastiera si limitano agli ’”incastrati prima di partire” o “stai verticale col busto”.
Quelli che sfornano campioni forniscono all’atleta gli strumenti per maturare un’idea di movimento sempre più chiara, inossidabile al carico, alla tensione nervosa. Alla paura.
Sensazioni, percezioni che si fondono nell’Uno.
Il curare l’esteriore necessita di una rivisitazione dell’interiore.
Gli errori grossolani non possono essere presenti in un contesto del genere: una chiara immagine di fronte ai nostri occhi elimina qualsiasi possibilità di sbavatura. Ed è qui che le sbavature, gli errori visti dal di fuori in realtà non sono errori.
Chi valuta “errore” una schienata con 400kg di squat non sa quel che dice.
Perché chi era lì sotto, sotto quella sbarra, ha visualizzato un movimento e l’ha portato a termine. Alla fine, è questo quel che conta.
Il risultato sportivo concreto – sempre che si gareggi ad armi pari, però! – pesa più di tutto.
La chiave è tutta nel percorso che ci porta fin lì.
L’impostazione tecnica rigida serve, eccome se serve! Ma non rappresenta la sola, assoluta soluzione. Fa parte di quegli strumenti che il coach utilizza per mettere l’atleta sul binario. Da lì si costruisce insieme.
Il bilancere schizza via veloce e deciso solo quando smettiamo di “sentire” i muscoli e passiamo alle idee di movimento. ANNI, ANNI di lavoro costante e durissimo, per arrivare a questo.
Capisco finalmente come devo muovermi quando ho cambiato l’immagine che il mio cervello cataloga come squat, rendendola un qualcosa di indefinibile ma – allo stesso tempo – assolutamente chiara. Chiara a me stesso.
L’automatismo di Sheiko è figlio di un’immagine, di un’unica sensazione.
E’ QUELLA che dà fluidità all’alzata, che dà dinamismo nei punti giusti e coerenza assoluta durante l’intera traiettoria.
Perché lo squat è UNA immagine. Una sola.
Non “ora vado indietro col culo, poi chiudo le ginocchia, apro il petto”, e così via.
Ogni “errore” o incongruenza motoria percepibili dal di fuori derivano da immagini poco nitide. Se mi trovo in buca e non so cosa fare, non è solo colpa dei muscoli. E’ perché riesco a vedere. Non so cosa faccio quando sono in basso.
Guardiamoci 100 video dei cinesi. Credo si percepisca chiaramente: l’avere iniziato i pesi da pre-adolescenti ha fatto sì che i movimenti siano per loro ovvi, elementari ed intrinsecamente legati alla loro persona.
Chiudiamo gli occhi. Pensiamo ad alzarci in piedi. Ecco, sono sicuro che ognuno di noi vede un’immagine, percepisce l’illuminarsi di una miriade di neuroni in un’indefinibile zona del cervello. L’idea è lì davanti a noi.
Ecco, quando lo squat attiverà un’area della nostra corteccia con questa stessa facilità, con questa stessa nitidezza, con questa stessa precisione… Saremo sul podio europeo.
O mondiale, se qualcuno ha idee meno chiare delle nostre.